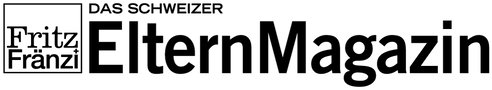Come posso rafforzare mio figlio? 11 fattori di resilienza
1. rilegatura sicura
L'esperienza precoce di un legame affettivo sicuro - idealmente con almeno un genitore - stabilisce ciò che lo psicoanalista tedesco-americano Erik Erikson ha definito «fiducia di base»: fiducia nel mondo e in se stessi. L'esperienza che i propri bisogni di protezione, sicurezza e amore sono soddisfatti in modo affidabile fin dalla nascita rafforza altri fattori protettivi che sono cruciali per un sano sviluppo psicologico: l'autostima, la regolazione emotiva e le abilità sociali del bambino. Chi ha imparato a fare affidamento sugli altri è anche più capace di mantenere le relazioni in seguito e di cercare sostegno nei momenti difficili.
2. uno stile genitoriale partecipativo
La ricerca sulla resilienza lo dimostra: Né la genitorialità autoritaria né il principio del laissez-faire favoriscono lo sviluppo dei bambini. La genitorialità partecipativa o autorevole offre condizioni migliori per sviluppare le competenze importanti per affrontare gli ostacoli. Non si basa sul ritiro dell'amore o su regole rigide, ma non permette nemmeno ai bambini di fare quello che vogliono. «Un'interazione tra attaccamento e guida», spiega Annette Cina dell'Istituto per la ricerca e la consulenza familiare dell'Università di Friburgo, «L'attaccamento costituisce la base: il bambino si sente accettato e amato dai genitori e sa di poter contare su di loro. Tuttavia, i bambini devono anche essere in grado di orientarsi verso i genitori. Per questo hanno bisogno di stabilire la direzione». Per esempio, con l'aiuto di regole che aiutino a strutturare la vita familiare quotidiana e che si concentrino sulla protezione del bambino.
Vale quanto segue: «Ciò che i genitori ritengono davvero importante non è negoziabile». Ma molte cose lo sono: i bambini dovrebbero avere voce in capitolo ed essere autorizzati ad ampliarla man mano che si sviluppano. È importante che i genitori pretendano che gli accordi vengano rispettati e che le conseguenze seguano se le cose non funzionano, Cina lo sa: «Lo scopo delle conseguenze è un processo di apprendimento: lasciamo che i bambini sperimentino le conseguenze delle loro azioni in modo che imparino gradualmente ad assumersene la responsabilità. Se un bambino si attarda continuamente la sera e non si prepara per andare a letto, una favola della buonanotte più breve non è una punizione, ma una conseguenza del fatto che non c'è abbastanza tempo per tutto».
3. supporto sociale al di fuori della famiglia
Persone che credono in noi, ci coprono le spalle e ci sono quando le cose si fanno difficili: Valgono tanto oro quanto pesano, e non necessariamente provengono dalla nostra famiglia. Gli adulti, in particolare, ricevono spesso questo sostegno da amici o da altri assistenti. «L'aspetto entusiasmante è che il solo fatto di sapere di poter contare su questo sostegno è spesso sufficiente a rafforzare le persone in crisi», afferma Isabella Helmreich del Leibnitz Institute for Resilience Research di Magonza. Numerosi studi hanno dimostrato l'importanza di questa rete, soprattutto per i bambini che ricevono poche cure a casa. Tuttavia, Helmreich sa che tutti i genitori farebbero bene a rafforzare questo fattore di resilienza - in loro stessi e nei loro figli: «Costruendo una rete sociale e mantenendola attivamente, dando l'esempio come genitori e promuovendo anche i contatti extra-familiari tra i figli; incoraggiandoli a raggiungere gli altri e a coltivare amicizie, per esempio».
Dovremmo insegnare a nostro figlio: Ciò che è andato storto può essere migliorato.
Friedrich Lösel, psicologo
4. buoni modelli di ruolo per un coping costruttivo
Il portatile si blocca, la presentazione va male, l'ingorgo non finisce mai: «Sappiamo quanto possa essere snervante la vita di tutti i giorni», dice Friedrich Lösel, professore emerito di psicologia e criminologia e pioniere della ricerca sulla resilienza in lingua tedesca. «È normale che a volte si alzino le mani. Tuttavia, non ogni fastidio deve diventare un motivo per lamentarsi». Chi si lamenta continuamente delle difficoltà che sta vivendo dà al figlio l'impressione che la vita sia difficile da affrontare: «Sarebbe meglio se segnalasse: Ora è fastidioso, ma possiamo ancora farcela. Oppure: Quello che è andato male può essere migliorato». La psicologia definisce questo modo produttivo e pragmatico di affrontare i fattori di disturbo come coping costruttivo. «Non funziona sempre», dice Lösel, «ma più spesso è, meglio è».
5. risoluzione attiva dei problemi
È altrettanto importante non evitare le difficoltà, ma affrontarle di petto. «La soluzione attiva dei problemi è un importante fattore di resilienza», afferma Lösel, ricercatore sulla resilienza, «e si contrappone al cosiddetto coping passivo, la cui forma più estrema è, ad esempio, affogare i dispiaceri nell'alcol». Anche in questo caso, secondo Lösel, i genitori dovrebbero essere consapevoli della loro funzione di modello e affrontare le lamentele prima o poi, senza evitare i sentimenti spiacevoli che potrebbero sorgere. Si tratta di difendere una decisione, anche nei confronti del figlio, o di chiedere aiuto ad altri in caso di difficoltà. «Dovreste anche tenere d'occhio se vostro figlio usa spesso strategie di evitamento e lavorare con lui per trovare delle alternative».
6. il pensiero positivo
«Se percepiamo un problema come risolvibile o ci sentiamo impotenti di fronte ad esso dipende, ad esempio, da come valutiamo le nostre risorse personali o il sostegno che riceviamo dagli altri», afferma la ricercatrice sulla resilienza Isabella Helmreich. «Anche la capacità di vedere il lato positivo nei momenti difficili gioca un ruolo decisivo». Questo atteggiamento ottimistico può essere allenato, «ad esempio dedicando regolarmente del tempo ai bambini per visualizzare l'esperienza di sentimenti positivi».
Se so cosa è importante per me, posso controllare la mia vita fino a un certo punto.
Isabella Helmreich, ricercatrice sulla resilienza
Il rituale serale di rivedere insieme la giornata e fare un bilancio consapevole sarebbe una buona idea: Quali sono stati i momenti positivi? Oppure il cosiddetto esercizio dei piselli: «Al mattino il bambino mette una piccola manciata di piselli nella tasca dei pantaloni e, ogni volta che vive un'esperienza positiva, sposta un pisello nell'altra. In questo modo è particolarmente chiaro che anche le giornate difficili hanno dei momenti positivi».
7. esperienza di senso, struttura e significato
Percepiamo fondamentalmente la vita e la nostra esistenza come significative, plausibili e gestibili? Sentiamo un senso di appartenenza all'ambiente che ci circonda? Il sociologo medico Aaron Antonovsky ha descritto questo tipo di stato mentale di base come «senso di coerenza». È come una bussola interiore che facilita la navigazione nella vita e nelle sue vicissitudini, come dimostrano gli studi di Antonovsky sui sopravvissuti ai campi di concentramento.
«Il senso di coerenza rafforza altri fattori di resilienza come l'ottimismo o l'autoefficacia», afferma lo psicologo Helmreich, «e ha molto a che fare con l'orientamento ai valori: Se so quali valori sono importanti per me e li ancoro nella mia vita quotidiana - ad esempio, la creatività o l'amicizia - non solo ne traggo soddisfazione, ma sperimento anche che posso controllare la mia vita in buona misura». È anche una buona idea parlarne con i bambini: Cosa è importante per te come persona e per noi come famiglia, come possiamo, puoi coltivare queste cose?".
8. esperienze di autoefficacia
Un termine ingombrante comunemente usato nella ricerca sulla resilienza è «aspettativa di autoefficacia». Si riferisce alla fiducia di poter superare le sfide da soli. «Le esperienze di autoefficacia rafforzano la convinzione di non essere in balia del corso degli eventi, ma di poterli influenzare attivamente», afferma Jürg Frick, docente all'Università di Zurigo per la formazione degli insegnanti ed esperto nella promozione della resilienza a scuola. «Per farlo, un bambino ha bisogno dell'opportunità di affrontare le sfide».
Frick è favorevole a richieste «misurate», adattate allo stadio di sviluppo del bambino, «che i bambini richiedono precocemente, ad esempio vestendosi da soli o volendo aiutare». Consiglia ai genitori di incoraggiare i bambini a provare le cose, anche se il maglione è al contrario, e di lasciarli provare se rompono un piatto. E di permettere loro di fallire, sempre a dosi: «I bambini devono imparare a scomporre i problemi in fasi parziali e a chiedere aiuto quando non riescono ad andare avanti. Questo non funziona se i genitori fanno tutto al posto loro». È importante chiedere attivamente l'aiuto dei bambini e non fare a meno di «Ämtli» perché gli adulti sono più veloci. «Dare un contributo responsabilizza i bambini», dice Frick.
9 Flessibilità mentale
Poiché l 'intelligenza consente di risolvere i problemi, è considerata un importante fattore di resilienza. «Tuttavia, in questo caso l'attenzione si concentra più sull'intelligenza pratica che sul quoziente intellettivo in sé», sottolinea Lösel, che ha analizzato lo sviluppo dei bambini in affidamento nell'ambito del primo studio sulla resilienza nei Paesi di lingua tedesca. «I bambini resilienti della nostra indagine non erano nemmeno molto dotati; erano caratterizzati da adattabilità mentale e da una visione realistica delle cose». La flessibilità mentale può essere allenata.
Non dobbiamo risparmiare ai nostri figli le emozioni negative, ma aiutarli a gestirle.
Simone Munsch, psicoterapeuta
A questo proposito, Lösel sottolinea l'effetto benefico delle «richieste misurate», come lo psicologo Frick cita in relazione all'autoefficacia. In sostanza, i bambini hanno bisogno di tempo per sviluppare la flessibilità mentale; le routine familiari sono particolarmente importanti per i più piccoli. «Tuttavia, come famiglia, si può decidere di affrontare le cose di tutti i giorni in modo diverso di tanto in tanto», afferma il ricercatore sulla resilienza Helmreich. «I bambini traggono beneficio anche quando parliamo loro di persone, approcci e prospettive diverse e li coinvolgiamo nelle nostre considerazioni sulla risoluzione dei problemi».
10. Buona regolazione delle emozioni
Affinché un giovane sia in grado di mobilitare la forza interiore in situazioni difficili, deve aver imparato a sopportare ciò che gli sembra spiacevole: che la risposta sia no, che l'insegnante abbia valutato male la lezione, che il vicino di casa giochi meglio a calcio - senza che i genitori cerchino di placarli o di risparmiare loro questi momenti. «La tolleranza degli affetti si riferisce alla capacità di sopportare sentimenti immediati, intensi e intensamente negativi», afferma Simone Munsch, responsabile del centro di pratica psicoterapeutica dell'Università di Friburgo. «La mancanza di tolleranza agli affetti gioca un ruolo chiave nei disturbi mentali. È importante che i genitori forniscano ai loro figli un terreno di formazione per esperienze di apprendimento adeguate, a partire dalla prima infanzia.»
Nel corso del suo sviluppo, il bambino deve imparare a dare un nome e a classificare i propri sentimenti. «I genitori possono aiutarli rispecchiando e verbalizzando le loro emozioni, ad esempio dicendo: 'Sei arrabbiato, vero? Oppure: 'È bello vedere che sei felice! La capacità dei genitori di rispondere con sensibilità alle esigenze dei bambini è di grande importanza in questo processo di apprendimento». Tuttavia, spesso viene fraintesa, come sa Munsch: «Non si tratta di risparmiare al bambino le emozioni negative, ma di dargli il sostegno di cui ha bisogno per imparare a gestirle. I genitori dovrebbero limitarsi a segnalare al bambino che sono presenti e che sono sicuri che andrà tutto bene. In realtà, le mamme e i papà spesso trovano questo difficile perché credono di dover risparmiare ai bambini la sofferenza».
11. competenza sociale
La conoscenza delle emozioni è importante anche per l'acquisizione di competenze sociali, che rappresentano un importante fattore di resilienza. Facendo da specchio e verbalizzando le emozioni al bambino, i genitori lo aiutano a sviluppare nel tempo non solo il senso dei propri sentimenti, ma anche di quelli degli altri. Le abilità sociali richiedono anche la capacità di empatizzare con gli altri. «Questa capacità si sviluppa a partire dall'età di tre anni e apre la strada all'aiuto e alla cooperazione», afferma Moritz Daum, responsabile di Psicologia dello sviluppo all'Università di Zurigo.
I genitori possono anche sostenere l'apprendimento sociale rendendo i collegamenti verbalmente tangibili per il bambino: «Guarda, la bambina sta piangendo. È triste. Ti ricordi quanto eri triste quando ti hanno tolto la pala?». In seguito, l'esempio dato dai genitori è fondamentale, dice Daum: «Come tratto gli altri come mamma o papà? Ascolto gli altri? Offro loro il mio sostegno? I bambini osservano attentamente il comportamento dei genitori in questo senso».