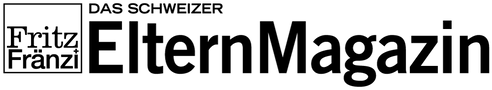12 domande sull'autismo
1. Quali sono le cause dell'autismo?
I disturbi dello spettro autistico sono principalmente di origine genetica. Finora sono stati identificati oltre 150 geni che interagiscono in diverse combinazioni. Questa interazione è talmente complessa che la ricerca non è ancora riuscita a comprenderla appieno.
Ma la presenza di un bambino autistico non implica necessariamente che anche uno dei genitori sia autistico. Tuttavia, capita spesso di riscontrare in uno dei genitori o in un parente stretto i cosiddetti tratti autistici: anomalie nella comunicazione sociale , nell'interazione con le persone o modelli comportamentali poco flessibili, che però non sono così numerosi né così gravi da compromettere la partecipazione della persona alla vita sociale e quotidiana.
I fattori ambientali influiscono soprattutto sui fattori di rischio durante la gravidanza, come le infezioni virali della madre o l'assunzione di determinati farmaci. È stato dimostrato che le ipotesi secondo cui l'autismo sarebbe dovuto a un'educazione fredda o ai vaccini sono errate.
Matthias Dose, esperto di autismo, diagnostico e psichiatra a Monaco di Baviera, membro del comitato scientifico consultivo di «Autismus Deutschland» (Autismo Germania)
2. Perché vengono diagnosticati più maschi che femmine?
Perché questi ultimi spesso passano più inosservati. Le ragazze e le donne, probabilmente a causa del loro condizionamento, sono spesso più competenti dal punto di vista sociale rispetto ai ragazzi e agli uomini, e questo vale anche per le persone autistiche. Le ragazze autistiche sono spesso più brave a identificare e imitare i comportamenti considerati socialmente desiderabili. Probabilmente gioca un ruolo anche il fatto che caratteristiche come l'estrema timidezza o il ritiro sociale, che possono essere associate all'autismo, sono considerate più femminili, mentre gli stessi tratti in un ragazzo potrebbero essere percepiti come strani.
Christine Preissmann, autistica con sindrome di Asperger, medico e terapeuta specializzata in disturbi dello spettro autistico, Rossdorf (Germania)
3. Quanto sono frequenti i disturbi dello spettro autistico?
La scienza ritiene che l'1% della popolazione sia affetto da un disturbo autistico. Il nostro centro specializzato preferisce un concetto dimensionale della malattia, piuttosto che classificare le persone come autistiche o non autistiche: la diagnosi di disturbo viene infatti attribuita solo a chi presenta caratteristiche autistiche più evidenti rispetto al 99% della popolazione restante. Naturalmente, anche le persone che rientrano nella fascia del 2-3% presentano tratti autistici, senza che venga loro diagnosticato l'autismo, ma questi sono nel complesso meno limitanti e non richiedono quindi misure così estese.
Per quanto riguarda i dati relativi al settore dell'infanzia e della gioventù, è necessario frenare attivamente, altrimenti si rischia l'inflazione.
Andreas Riedel, psichiatra
Offriamo a queste persone terapie che non riguardano solo, ma anche, tematiche tipiche dell'autismo. Affinché la ricerca abbia un effetto, la diagnosi non deve essere arbitraria. Dovremmo attenerci all'1% che, tra l'altro, non abbiamo ancora diagnosticato negli adulti in questo Paese. Per quanto riguarda i dati relativi ai bambini e agli adolescenti, invece, è necessario frenare attivamente, altrimenti si rischia l'inflazione.
Andreas Riedel, psichiatra e medico responsabile del centro specializzato nei disturbi dello spettro autistico nell'età adulta presso la Clinica psichiatrica di Lucerna
4. A che età si manifesta un disturbo dello spettro autistico?
Per definizione, inizia sempre nella prima infanzia. Tuttavia, è possibile che si manifesti completamente solo in un secondo momento, quindi i comportamenti tipici non vengono riconosciuti come tali per molto tempo. Questo può essere dovuto al fatto che, in una certa misura, tali comportamenti sono presenti anche nei genitori, che tendono a seguire modelli che vanno incontro alle esigenze di un bambino autistico. O semplicemente perché le famiglie sono molto solide, i genitori hanno sviluppato un'elevata tolleranza per le peculiarità del proprio figlio e hanno sviluppato un senso di ciò di cui ha bisogno in termini di struttura o equilibrio. Si rendono conto che il loro bambino percepisce il mondo in modo diverso, senza specificarlo in modo più dettagliato.
Se poi, ad esempio in campagna, il bambino è sostenuto anche da una scuola piccola e familiare, ci accorgiamo di questi casi solo in una fase avanzata, di solito quando le esigenze sociali superano le loro capacità limitate e il loro bisogno di prevedibilità, ad esempio nelle classi superiori, durante l'apprendistato o gli studi universitari. Questo vale anche per i bambini che non erano stati individuati perché a scuola erano molto timidi e silenziosi.
Charlotte Gwerder, psicologa infantile e giovanile, responsabile del centro specializzato per l'autismo presso le cliniche psichiatriche universitarie di Basilea
5. Come viene diagnosticato l'autismo?
L'autismo è una diagnosi clinica. Ciò significa che non esiste un test medico in grado di escludere o confermare al 100% un disturbo autistico. La diagnosi dell'autismo è complessa e deve essere effettuata in modo differenziato. Si tratta, tra l'altro, di acquisire un'impressione approfondita dello sviluppo del bambino fino a quel momento. A tal fine, i genitori e altre persone di riferimento e specialisti vengono intervistati secondo linee guida standardizzate, che riguardano le tappe fondamentali dello sviluppo, i comportamenti nella prima infanzia e così via. Queste interviste possono durare fino a tre ore.
Fino all'80% delle persone affette da disturbi dello spettro autistico presenta anche altre diagnosi.
Charlotte Gwerder, psicologa infantile e giovanile
A ciò si aggiungono osservazioni comportamentali sotto il profilo specifico dell'autismo. Nei bambini più piccoli ciò avviene in modo ludico, mentre negli adolescenti prevalentemente attraverso il dialogo. Speciali strumenti di valutazione consentono di creare diverse situazioni sociali in cui è possibile riconoscere particolarmente bene i comportamenti autistici o piuttosto escluderli. Infine, nell'analisi vengono integrati gli osservazioni cliniche, le valutazioni delle interviste e dei test, nonché le descrizioni del bambino e delle persone di riferimento.
Matthias Huber, psicologo, diagnostico di lunga data presso la clinica universitaria UPD di Berna e oggi esperto presso il centro di consulenza della Fondazione Kind & Autismus (Bambini e autismo)
6. I bambini affetti da autismo sono anche più soggetti ad altri disturbi?
Senza dubbio. Fino all'80% delle persone affette da un disturbo dello spettro autistico presenta anche altre diagnosi. Nell'infanzia e nell'adolescenza, l'ADHD e l'ADD sono i disturbi concomitanti più frequenti (60%), la cui insorgenza è determinata da costellazioni genetiche simili.
Esistono inoltre cluster genetici sovrapposti correlati alla predisposizione a disturbi ossessivo-compulsivi, d'ansia o depressivi. Per quanto riguarda questi ultimi, i bambini autistici sono probabilmente più a rischio anche perché sono sottoposti a una forte pressione di adattamento e vivono molto più spesso l'esperienza di non essere all'altezza. La pressione costante e il sovraccarico nel campo sociale possono inoltre portare a disturbi d'ansia sociale.
Charlotte Gwerder
7. Cosa si intende per «mascheramento» in relazione all'autismo?
Il «mascheramento» consiste in strategie che le persone autistiche acquisiscono per compensare le difficoltà sociali. Mentre i bambini non autistici imparano e applicano intuitivamente i segnali sociali, un bambino autistico non è in grado di farlo. Così, fin da piccolo, gli viene detto dalle persone di riferimento che deve guardarle negli occhi quando parla. Gli verrà detto che per salutare bisogna sorridere, i coetanei gli chiederanno di parlare «normalmente». Al bambino viene spiegato chiaramente quale sia il comportamento socialmente accettato e lui cerca, nei limiti delle sue possibilità, di interiorizzare tali regole.
Quando i bambini piccoli consumano molti media, ciò può talvolta portare a comportamenti anomali che possono essere tipici o simili ai disturbi dello spettro autistico.
Charlotte Gwerder, psicologa infantile e giovanile
In molti autistici il risultato è quello che è: appreso e poco naturale. Alcuni sviluppano nel tempo sofisticate strategie di compensazione. A prima vista sembrano soddisfare criteri oggettivi relativi al contatto visivo, alla gestualità o all'intonazione della voce, ma a un secondo sguardo, almeno io come diagnostico, noto che manca la finezza sociale: il sorriso appare stereotipato, il contatto visivo è poco variato, la gestualità non è diretta verso di me, ma va nel vuoto, solo per fare alcuni esempi.
Andreas Riedel
8. Cosa si intende per pseudo-autismo?
Quando i bambini piccoli consumano molti media, ciò può talvolta portare a comportamenti anomali che possono essere tipici o simili ai disturbi dello spettro autistico. Ad esempio, può verificarsi la cosiddetta ecolalia: i bambini ripetono in modo ripetitivo e quasi meccanico parole e frasi pronunciate da altre persone, in questo caso tipicamente dalla televisione. Spesso preferiscono l'inglese, che conoscono dai media, prima di imparare la propria lingua madre.
Non solo presentano un ritardo linguistico, ma anche un ritardo nello sviluppo sociale ed emotivo. Sembrano autistici, ma non lo sono: mancano di interazione sociale, di sicurezza affettiva e quindi di stimoli all'apprendimento. L'esperienza dimostra tuttavia che possono recuperare il loro deficit di sviluppo se si riduce il loro consumo di media e si forniscono consigli adeguati ai genitori.
Charlotte Gwerder
9. Cosa si intende per autistici «ad alto funzionamento»?
Il termine indica persone autistiche che non presentano limitazioni delle capacità cognitive o del linguaggio funzionale. Hanno quindi un'intelligenza nella media o superiore alla media e padroneggiano il linguaggio verbale.
Matthias Huber
10. Su Internet circola una nuova diagnosi: la Pathological Demand Avoidance (PDA) si riferisce al rifiuto delle richieste quotidiane ed è considerata un'altra forma di autismo. Di cosa si tratta?
Il PDA descrive un profilo comportamentale di bambini o adulti che reagiscono con avversione alle esigenze quotidiane. Ma chiariamo subito: il PDA non è una diagnosi scientificamente riconosciuta né un sottotipo di autismo – sono soprattutto i genitori a richiederlo. Il PDA non sarà una diagnosi ufficiale nel prossimo futuro, perché non esistono ricerche in merito. Esistono migliaia di studi sui disturbi dello spettro autistico e undici lavori internazionali sul PDA, considerati di scarsa qualità.
Inge Kamp-Becker, ricercatrice sull'autismo, diagnostica e professoressa presso la Clinica di psichiatria infantile e giovanile dell'Ospedale universitario di Heidelberg
Le tre forme di autismo
L'autismo infantile è considerato la forma più grave di disturbo autistico. I bambini affetti da questa forma di autismo mostrano fin dal primo anno di vita limitazioni nella comunicazione sociale: lo sviluppo del linguaggio è assente, ritardato o frammentario. Anche nell'interazione sociale si notano presto anomalie: il contatto visivo, la mimica e la gestualità sono ridotti o non vengono utilizzati per entrare in relazione con le persone. Alcuni soggetti recuperano il ritardo nel linguaggio, altri non parlano nemmeno in età adulta. Il quadro clinico comprende anche comportamenti ripetitivi e stereotipati: molti bambini, ad esempio, si distinguono per il dondolio costante del busto o il battito delle mani. Tipico è anche l'attaccamento quasi compulsivo alle abitudini. L'autismo infantile è spesso accompagnato da un deficit cognitivo e viene diagnosticato prima dei tre anni di età.
Anche nella sindrome di Asperger si riscontrano limitazioni nella comunicazione e nell'interazione sociale, nonché modelli comportamentali ripetitivi e stereotipati. Tuttavia, lo sviluppo linguistico e cognitivo delle persone colpite nei primi tre anni di vita è generalmente normale. Le difficoltà si manifestano quando trascorrono più tempo con i coetanei, ad esempio all'asilo o alla scuola materna. In questi contesti, i bambini affetti dalla sindrome di Asperger mostrano spesso scarso interesse per gli altri bambini e hanno difficoltà a entrare in contatto con loro. Durante le attività di gruppo sembrano disinteressati, introversi o provocatori perché non interagiscono con gli altri e insistono sulle proprie regole, oppure reagiscono in modo impulsivo quando qualcuno le mette in discussione. La comunicazione con loro è spesso fonte di malintesi: oltre alla comprensione letterale del linguaggio, tipica di molti di loro, alcuni hanno un modo di parlare monotono o pedante. Anche i bambini con sindrome di Asperger hanno difficoltà a discostarsi dalle abitudini e alcuni di loro hanno interessi particolari molto marcati, atipici per la loro età e il loro contesto sociale.
L'autismo atipico viene interpretato in modo diverso nella pratica: mentre alcuni esperti interpretano il termine nel senso che non tutte e tre le aree di riferimento – comunicazione sociale, interazione sociale e comportamenti ripetitivi e stereotipati – presentano anomalie o che queste compaiono solo in un secondo momento, altri lo associano a deficit intellettivi particolarmente gravi.
11. Un disturbo dello spettro autistico può scomparire con la crescita?
Assolutamente sì. Ci sono persone affette da questo disturbo che, nel corso della loro vita, grazie all'esperienza acquisita e a trattamenti efficaci, vedono i sintomi ridursi a tal punto da diventare praticamente impercettibili. Si tratta però di una minoranza.
In generale, il decorso del disturbo è molto individuale e anche le prognosi sono molto diverse. Queste sono nettamente peggiori se un bambino non impara a parlare e presenta anche un deficit cognitivo. È tuttavia un dato di fatto che oggi molti più bambini autistici, anche quelli gravemente affetti, imparano a parlare rispetto a 20 anni fa, perché grazie a interventi precoci mirati e basati su dati scientifici riusciamo a stimolare in modo mirato le funzioni precursori del linguaggio, come il contatto visivo, la capacità di focalizzare l'attenzione su qualcosa di comune e la capacità di imitazione.
Inge Kamp-Becker
Gli autistici sono perfettamente in grado di provare empatia, ma è necessario parlare chiaramente affinché capiscano cosa sta succedendo.
12. Quali miti sull'autismo devono essere sfatati con urgenza?
Ce ne sono diversi. Ad esempio l'affermazione che gli autistici non siano capaci di provare empatia. Lo sono eccome, ma bisogna parlare chiaro affinché capiscano di cosa si tratta. Ricordo che qualche anno fa una collega di lavoro disse che presto sarebbe andata in aria. Le chiesi quali fossero i suoi programmi di viaggio, ma lei rispose che non stava andando in vacanza, bensì era arrabbiata. Solo allora capii e potei approfondire la questione.
Certo, sono meno empatico degli altri. Ma non è vero che non mi interessano i sentimenti degli altri, semplicemente devono essere espressi in modo più chiaro. Ciò che è fondamentalmente sbagliato è pensare che le persone con autismo non desiderino avere contatti sociali, amici o partner. La stragrande maggioranza delle persone che ho conosciuto desidera avere relazioni di questo tipo, ma purtroppo spesso non riesce a instaurarle o a mantenerle.
Christine Preissmann