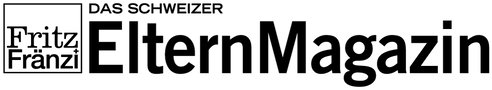Il Ritalin per l'ADHD: una maledizione o una benedizione?
Il fenomeno del bambino irrequieto non è nuovo. La storia dei termini utilizzati per descrivere il fenomeno lo ricorda: si va dal noto «fidget spinner» della fine del XIX secolo alla POS (sindrome psico-organica) degli anni '60/'70 fino all'odierno termine ADHD.
Lo stesso fenomeno viene sempre descritto, ma spiegato e trattato in modo diverso in ogni caso. La novità è rappresentata dall'uso diffuso di farmaci, i cosiddetti metilfenidati (MPH, ad esempio il Ritalin), per il trattamento della pigrizia. Ma anche questo sviluppo è ormai superato: Il trattamento farmacologico dell'ADHD ha conosciuto il suo primo boom negli anni '80 negli Stati Uniti e ha raggiunto l'Europa poco più tardi.
Diagnosi e trattamento dell'ADHD
L'abbreviazione ADHD sta per disturbo da deficit di attenzione e iperattività e deriva dalla diagnostica psichiatrica. Il termine ADHD ha origine in inglese; nei Paesi di lingua tedesca è spesso indicato come disturbo ipercinetico.
Entrambe le definizioni descrivono un disturbo dell'attenzione e dell'attività nella persona colpita. È importante notare che oggi nella psichiatria infantile e adolescenziale si applica il principio del trattamento multimodale dell'ADHD, vale a dire che i bambini con ADHD dovrebbero sempre ricevere una combinazione di misure e trattamenti diversi. Oltre alla psicoterapia, ciò include anche programmi di consulenza e di formazione educativa per i genitori. Il trattamento farmacologico è consigliato solo nei casi di ADHD grave.
Il trattamento farmacologico dell'ADHD con il Ritalin è consigliato solo nei casi più gravi e non come unica terapia.
In questo contesto, ci si chiede come mai negli ultimi anni si sia verificato un forte aumento dei trattamenti con Ritalin. Ritalin, un farmaco popolare? Ci sono effettivamente notizie di un preoccupante aumento dei trattamenti con Ritalin in Svizzera.
Ma su quali cifre possiamo effettivamente fare affidamento? Sono disponibili solo studi limitati nel tempo e nella geografia. Ad esempio, uno studio del Cantone di Zurigo mostra che le prescrizioni di MPH per i bambini in età scolare sono aumentate dall'1,5% nel 2006 al 2,6% nel 2012 [1]. In teoria sono ipotizzabili le seguenti ragioni:
A) Più bambini sono stressati:
In Svizzera è aumentata l'incidenza dei bambini stressati.
B) Viene diagnosticato un numero maggiore di bambini:
La frequenza dei casi riconosciuti o diagnosticati è aumentata.
C) Un numero maggiore di bambini riceve farmaci:
È aumentata la frequenza con cui ai bambini viene prescritto l'MPH.
La spiegazione A (più bambini «malati») sembra improbabile, poiché un raddoppio dei bambini affetti in quattro anni è difficilmente prevedibile sulla base dei dati di altri Paesi. Le spiegazioni B e C sono più plausibili: negli ultimi anni è stato diagnosticato l'ADHD a un maggior numero di scolari, ad esempio grazie a valutazioni più frequenti, e/o una percentuale crescente di bambini diagnosticati è stata trattata con farmaci.
La variante C2 sembra meno probabile perché nella maggior parte dei casi il farmaco è prescritto da uno specialista. È importante notare che l'aumento dei trattamenti MPH non è necessariamente dovuto a un cambiamento delle preferenze terapeutiche verso «più farmaci»; può anche essere spiegato solo dall'aumento dei chiarimenti o dei casi diagnosticati.
ADHD e medicalizzazione
I risultati di questo breve excursus indicano che la crescente importanza dell'ADHD tra i bambini in età scolare non è dovuta esclusivamente al maggiore stress a cui sono sottoposti i bambini. Sembra piuttosto che l'ambiente dei bambini, cioè genitori e insegnanti, stiano reagendo in modo diverso a un fenomeno che è sempre esistito. Oggi si risponde spesso in modo «terapeutico» o «medico» a comportamenti che non sono più considerati accettabili nelle loro manifestazioni.
È qui che entra in gioco la teoria sociologica della «medicalizzazione». Con questo termine si intende la teoria secondo la quale i comportamenti e le esperienze più evidenti vengono spiegati come espressione di un disturbo della salute e trattati dal punto di vista medico. La prospettiva storica gioca un ruolo importante in questo caso: si tratta di comportamenti che in precedenza non erano visti come un problema di salute o una malattia, ma piuttosto come un problema disciplinare, educativo o addirittura un destino di vita.
Genitori e insegnanti reagiscono oggi in modo molto diverso a un fenomeno che è sempre esistito.
Questi fenomeni vengono ora resi accessibili alla medicina e classificati con una diagnosi specifica. L'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche ha descritto la medicalizzazione nel modo seguente: «Si parla di medicalizzazione quando, ad esempio, lo stress sul lavoro o le eccessive richieste di cura dei figli portano a sintomi che vengono trattati dal punto di vista medico; in altre parole, quando, invece di affrontare le cause sociali, la soluzione dei problemi viene affidata alla responsabilità dei medici» [2].
La tesi della medicalizzazione è stata sviluppata dal sociologo americano Peter Conrad. Egli ha descritto i seguenti fattori di medicalizzazione: in primo luogo, lo sviluppo della diagnostica psichiatrica. Lo si può vedere, ad esempio, nel manuale diagnostico americano per la psichiatria, dove il numero di diagnosi è quasi triplicato da 102 a 297 tra il 1952 e il 1994.
In secondo luogo, a partire dagli anni Cinquanta sono apparsi sul mercato i primi psicofarmaci che potevano essere utilizzati per il trattamento delle malattie mentali. In terzo luogo, infine, è cambiato anche il comportamento dei potenziali pazienti: Oggi sono anche consumatori sul mercato sanitario, sono informati e vogliono prendere decisioni il più possibile autonome.
In questo contesto, gli esperti riferiscono che la diagnosi di ADHD non è sempre valida sotto la pressione dei genitori che si aspettano un aiuto rapido per i problemi dei loro figli.
La serie ADHD in sintesi
Parte 2: Mio figlio ha l'ADHD
Parte 3: Bambini malati o società malata?
Parte 4: ADHD: quali diritti hanno i bambini?
Parte 5: ADHD e scuola
Parte 6: Ritalin per l'ADHD - maledizione o benedizione?
Parte 7: La diagnosi di ADHD
Parte 8: Mio figlio ha l'ADHD - e adesso?
Parte 9: ADHD e aspetti etici del trattamento
Parte 10: ADHD e psicoterapia
Parte 11: Terapia dell'ADHD senza farmaci. Grandi benefici, piccoli rischi
È possibile scaricare la serie di 11 parti sull'ADHD in formato PDFqui
Conseguenze
La medicalizzazione non è di per sé qualcosa di negativo. Soprattutto nell'ambito delle malattie mentali, è noto anche il fenomeno quasi inverso, per cui i problemi mentali rimangono a lungo non trattati, a volte con gravi conseguenze per le persone colpite. Tuttavia, la medicalizzazione comporta dei rischi che non devono essere sottovalutati:
- La patologizzazione di condizioni che prima erano considerate gravi, ma che alla fine sono diventate comuni. Il pericolo è che siamo sempre meno capaci di affrontare situazioni difficili senza l'aiuto di esperti.
- Individualizzazione dei problemi comportamentali. L'attenzione si concentra sul comportamento e meno sulle circostanze che contribuiscono ai problemi. Per quanto riguarda l'ADHD, ad esempio, si nota che si discute relativamente poco della misura in cui le richieste di attenzione da parte della scuola contribuiscono alla diagnosi di ADHD.
- Il cambiamento della norma sociale di ciò che è considerato un comportamento «normale» o «sano». L'OMS ha definito la salute come uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, che va oltre la semplice assenza di malattia o infermità. In base a questo criterio, non sempre siamo in uno stato di massimo benessere, ma questo non significa che siamo considerati malati.
È sbagliato demonizzare il trattamento farmacologico dei DSA, contribuendo così a stigmatizzare ulteriormente i genitori.
Da questo punto di vista, il processo di medicalizzazione può anche essere descritto come uno spostamento del confine della necessità di trattamento medico di un problema verso la salute. Come risultato di questo spostamento, lo spettro di condizioni e comportamenti che sono ancora considerati sani si sta generalmente restringendo. Tuttavia, più questo spettro si restringe, più persone hanno bisogno di cure e più misure sono necessarie.
Conclusione
Lo sviluppo delle diagnosi di ADHD e il trattamento dei bambini affetti dovrebbero continuare a essere monitorati in modo critico. Bisogna tenere conto della sofferenza, spesso grande, di genitori e bambini: sarebbe sbagliato demonizzare in linea di principio il trattamento farmacologico dell'ADHD, contribuendo così a stigmatizzare ulteriormente i genitori.
Tuttavia, è necessario prestare maggiore attenzione alle capacità locali di risoluzione dei problemi, al di là del ricorso a interventi medici o terapeutici. In particolare, occorre considerare l'interazione tra casa e scuola. Entrambe le aree sono così interdipendenti che gli interventi che si rivolgono solo a una di esse rischiano di avere un successo limitato.
Ci si chiede come sia i genitori che gli insegnanti possano essere meglio supportati nel guidare con successo i bambini con problemi di attenzione nella vita quotidiana, senza ricorrere ai farmaci. È inoltre necessario esaminare come i requisiti del programma scolastico possano essere più tolleranti e flessibili rispetto ai ritmi e alle esigenze di apprendimento di questi bambini.
Che cos'è l'ADHD?
Questa serie di dieci puntate è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto di ricerca e consulenza familiare dell'Università di Friburgo, sotto la direzione della dottoressa Sandra Hotz. Insieme ad Amrei Wittwer del Collegium Helveticum, l'avvocato guida il progetto «Kinder fördern. Uno studio interdisciplinare», al quale partecipa anche l'Università di Scienze Applicate di Zurigo ZHAW. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Mercator Svizzera.
Diagnosi di ADHD
Secondo il DSM-5, per la diagnosi di ADHD devono essere identificati almeno sei sintomi dei fenomeni focali di disattenzione o iperattività/impulsività (Criterio I). I sintomi devono essersi manifestati negli ultimi sei mesi e in misura incompatibile con lo stadio di sviluppo del bambino.
Inoltre, per la diagnosi di ADHD devono essere soddisfatti altri quattro criteri principali. I sintomi avversi devono essersi manifestati prima dei dodici anni (criterio II) e almeno due aree della vita devono essere perturbate dai sintomi (criterio III): Inoltre, deve esserci una chiara evidenza di compromissione in ambito scolastico, sociale o lavorativo (criterio IV).
Inoltre, i sintomi non possono essere spiegati da un disturbo dello sviluppo, dalla schizofrenia o da un altro disturbo psicotico o non sono scatenati da un'altra malattia mentale (criterio V). L'ICD-10 definisce il disturbo ipercinetico «con un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di persistenza in attività che richiedono uno sforzo cognitivo e una tendenza a passare da un'attività all'altra senza portare a termine nulla; inoltre, è presente un'attività disorganizzata, poco regolata e finale».