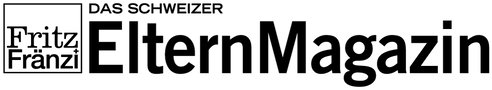Come l'inclusione ha successo
Quando Sophie viene a scuola, ci sono diversi assistenti che si occupano di lei. Naturalmente c'è l'insegnante, a cui può fare domande. Ma di solito accanto a Sophie siede anche un insegnante di sostegno. Lui o lei le ricorda di rispettare i compiti o le spiega di nuovo le cose che non ha capito(vedi la relazione «Voglio rispettare i compiti»).
Sophie ha diritto a questa assistenza speciale. Ha un «bisogno educativo speciale» riconosciuto . Poiché Sophie ha la sindrome di Down , ha più difficoltà della maggior parte degli altri alunni a comprendere i contenuti e a concentrarsi per lunghi periodi di tempo.
Nelle classi della scuola inclusiva, gli alunni con determinati «disturbi funzionali» vengono istruiti insieme agli alunni normalmente dotati. Si tratta di bambini con disabilità, disturbi dell'apprendimento, basso quoziente intellettivo, autismo, ADHD o disturbi comportamentali. Fino a pochi anni fa, in Svizzera questi alunni venivano insegnati principalmente in scuole speciali o in piccole classi speciali all'interno di scuole tradizionali.
Nelle classi della scuola inclusiva, gli alunni con determinati «disturbi funzionali» vengono istruiti insieme agli alunni normalmente dotati. Si tratta di bambini con disabilità, disturbi dell'apprendimento, basso quoziente intellettivo, autismo, ADHD o disturbi comportamentali. Fino a pochi anni fa, in Svizzera questi alunni venivano insegnati principalmente in scuole speciali o in piccole classi speciali all'interno di scuole tradizionali.
Apprendere insieme con obiettivi di apprendimento diversi
Mentre le scuole speciali continuano a esistere, le classi piccole sono state abolite in quasi tutti i cantoni. Si tratta di un passo avanti rispetto a un modello di scuola segregata verso un modello integrato. Uno dei motivi è la normativa svizzera. Sebbene i genitori non possano ancora fare causa per ottenere un posto in una scuola normale, diversi testi di legge affermano che l'integrazione deve essere privilegiata ogni volta che è possibile. Dal 2004, la legge sull'uguaglianza dei disabili obbliga i cantoni a promuovere l'integrazione degli alunni con «bisogni educativi speciali».
Anche le leggi cantonali sulla scuola primaria, approvate dall'elettorato, prevedono l'integrazione. Lo scorso maggio, la Svizzera è stata il 144° dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite a ratificare la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Questa stabilisce che le persone disabili devono avere pari accesso a un sistema scolastico inclusivo e di qualità. L'apprendimento deve avvenire insieme, anche se in alcuni casi con obiettivi di apprendimento diversi.
Quest'anno si analizzerà il grado di attuazione della Convenzione ONU. «L'onere della prova è stato invertito», afferma il professor Peter Lienhard dell'Università intercantonale per l'educazione dei bisogni speciali di Zurigo, riassumendo la situazione in Svizzera. «In passato, i genitori dovevano dimostrare che il proprio figlio era idoneo all'istruzione in una scuola normale, mentre ora la scuola deve dimostrare che ciò non è possibile».
La diversità come punto di forza
Alla base della Convenzione ONU c'è l'ideologia dell'inclusione: secondo questa, non sono più i bambini a dover essere testati per vedere se sono adatti al sistema scolastico standardizzato, ma sono le scuole a doversi adattare alla diversità dei bambini.
L'inclusione riconosce tutti gli alunni come individui con le proprie esigenze di apprendimento e i propri punti di forza. Gli alunni con disabilità non si distinguono più, ma hanno semplicemente un profilo diverso di punti di forza. L'inclusione fa quindi un passo avanti rispetto all'integrazione. Con l'integrazione, si definisce ancora chiaramente - di solito attraverso la diagnosi di un disturbo funzionale - chi è la norma e chi deve essere integrato. L'inclusione richiede quindi un modo diverso di pensare che vede la diversità come un punto di forza, non come un problema.
L'inclusione significa che non è il bambino a doversi adattare alla scuola, ma la scuola alle esigenze dei bambini.
Ma un sistema scolastico, anzi un'intera società, non cambia da un giorno all'altro. Per questo motivo, oggi la prassi scolastica svizzera favorisce soprattutto l'integrazione, per così dire come fase preliminare all'inclusione. Ciò significa che i bambini con una determinata diagnosi del servizio di psicologia scolastica ricevono misure per compensare il loro svantaggio.
Ad esempio, ausili tecnici, lezioni di recupero, compiti più semplici, la possibilità di sostenere un esame orale o il supporto di un insegnante curativo o con esigenze speciali. Nella maggior parte dei cantoni, tutte le classi hanno diritto a un livello base di supporto educativo speciale, che diventa tanto più elevato quanto più i bambini sono integrati nella rispettiva classe.
Integrazione a scuola significa uscire dallo stigma delle classi piccole
Numerosi studi dimostrano che i progressi di apprendimento dei bambini con difficoltà di apprendimento e di rendimento sono maggiori nelle classi inclusive che in quelle separate. Tuttavia, questo non è l'unico motivo per cui le classi piccole non esistono più nella maggior parte dei cantoni. C'entra anche lo stigma che vi è associato.
Urs Haeberlin, ex direttore dell'Istituto per l'educazione ai bisogni speciali dell'Università di Friburgo e responsabile di molti progetti di ricerca sull'integrazione, ha osservato che dal 1990 sempre meno bambini svizzeri sono stati educati in classi piccole. In molti luoghi, queste classi sono diventate un contenitore per bambini provenienti da famiglie immigrate svantaggiate dal punto di vista educativo, nonché per alunni con problemi comportamentali e bambini provenienti da contesti familiari difficili. Questo ha portato anche ai problemi che molti bambini hanno dovuto affrontare dopo aver lasciato la scuola.
Uno studio longitudinale svizzero del 2011 ha mostrato che molti studenti deboli frequentano programmi ponte dopo aver lasciato la scuola. Tuttavia, nel secondo e terzo anno dopo il diploma, molti più studenti deboli provenienti da classi regolari integrative trovano accesso a un apprendistato. Gli alunni provenienti da classi piccole, invece, hanno maggiori probabilità di cadere nel dimenticatoio - la loro reputazione nelle aziende di formazione è scarsa.
Sempre più alunni con bisogni speciali?
Ma cosa succede agli alunni difficili senza diagnosi? Dove finiscono quando le classi piccole vengono chiuse? Lo scorso autunno, i media hanno riferito di un «aumento esplosivo del numero di alunni con bisogni speciali», come mai prima d'ora. Si è ipotizzato che un numero particolarmente elevato di alunni venisse semplicemente diagnosticato affinché le scuole ricevessero più fondi e personale.
Beat Zemp, presidente dell'Associazione Svizzera degli Insegnanti (LCH), in un'intervista al portale internet «Watson» ha relatizzato che le cifre non possono essere confrontate senza ulteriori approfondimenti: «Il fatto che queste piccole classi siano state abolite e che la maggior parte degli alunni interessati sia stata integrata nelle classi normali aumenta automaticamente il numero dei cosiddetti alunni con bisogni speciali integrati nelle statistiche».
Inoltre, il Dipartimento svizzero dell'educazione dispone di una procedura di valutazione standardizzata e intercantonale solo dal 2014. Questa stabilisce i criteri che indicano chi è un alunno con esigenze speciali e quali misure sono appropriate.
In linea di principio, tuttavia, oggi si applica il «principio dell'istruzione», non più il «principio dell'assicurazione» che si applicava prima che l'AI si ritirasse dal finanziamento dell'istruzione speciale, secondo Peter Lienhard.
L'inclusione è un tema che incute timore ai genitori
Ciò significa: «Guardiamo a ciò di cui il bambino ha bisogno per raggiungere il suo obiettivo educativo. Non tanto il disturbo che ha». Ed è qui che entrano di nuovo in gioco i bambini che non hanno una disabilità chiaramente diagnosticata. Anche alcuni di loro hanno bisogno di aiuto per realizzare il proprio potenziale.
Un esempio pratico: nella classe 4i della scuola secondaria Leonhard di Basilea, gli insegnanti di recupero tengono d'occhio anche gli alunni deboli o con problemi comportamentali che non hanno un certificato medico o psicologico. Ad esempio, una ragazza giapponese trasferitasi in Svizzera solo da poche settimane.
Sembra essere normalmente dotata, ma parla solo inglese. Oppure una ragazza proveniente da un contesto migratorio che è molto insicura e non osa fare errori. Gli insegnanti di recupero si concentrano anche su di loro e lavorano con loro per elaborare obiettivi di apprendimento personalizzati e piani di sostegno.
Studio Bertelsmann
La ragazza giapponese riceve anche lezioni di recupero di «tedesco come seconda lingua». Secondo Peter Lienhard, il fatto che gli insegnanti di recupero non siano presenti solo per gli alunni con uno status di integrazione come quello di Sophie, ma abbiano anche del tempo da dedicare a questi casi, è dovuto al fatto che gli insegnanti e gli insegnanti di recupero della Sek Leonhard combinano intelligentemente le classi e le materie, mettendo così in comune le proprie risorse.
«È molto intelligente: è proprio così che bisogna fare perché l'integrazione funzioni», afferma Lienhard. Perché una cosa è chiara: l'integrazione non solo richiede molto agli insegnanti di sostegno, ma anche agli insegnanti e ai genitori.
«C'è incertezza tra molte persone: l'inclusione è un argomento che incute timore», afferma Bettina Ledergerber, responsabile della comunicazione di Pro Infirmis. L'organizzazione specializzata fornisce consulenza principalmente ai genitori di bambini con disabilità, ma anche agli insegnanti e alle autorità. Funge da traduttore per il gergo tecnico e aiuta a richiedere i diritti. Ledergerber descrive il sistema scolastico svizzero come «in fase di radicale cambiamento».
I bambini con difficoltà di apprendimento e di rendimento fanno maggiori progressi nelle classi comuni.
La visione dell'inclusione, che vede la diversità delle persone come un punto di forza, è un ordine alto. E la sua attuazione è anche alla mercé di un costante controllo da parte dei media. Mancanza di formazione, scarsità di risorse e i media trovano ripetutamente insegnanti che si lamentano del fatto che le normali lezioni con alunni così diversi sono difficilmente realizzabili. Molti insegnanti non hanno una formazione adeguata per gestire gli alunni integrati.
I moduli per l'integrazione e l'educazione ai bisogni speciali fanno parte della formazione degli insegnanti nelle scuole di formazione per insegnanti solo da pochi anni. Tuttavia, sono soprattutto gli insegnanti più anziani a doversi riqualificare, se ci sono soldi e tempo a disposizione. Quando lo scorso autunno il quotidiano Tages-Anzeiger ha dato la possibilità agli insegnanti sovraccarichi di dire la loro in un articolo, il 73,6% dei lettori online ha risposto negativamente alla domanda "Gli alunni con bisogni speciali appartengono alle classi comuni?
Alcune scuole hanno troppe poche risorse
Sono soprattutto i genitori degli alunni normodotati a temere che i bambini vengano frenati nel loro sviluppo se gli alunni deboli e quelli con bisogni speciali vengono inseriti nella stessa classe. Nella «Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik», Urs Strasser mostra l'effetto dei contesti inclusivi sugli alunni normodotati: essi sviluppano migliori abilità sociali, non vengono frenati e, contrariamente ai timori, fanno persino progressi particolarmente buoni.
In Germania, la Fondazione Bertelsmann ha condotto un sondaggio tra i genitori nel 2015, da cui è emerso che i genitori assegnano alle scuole inclusive buoni voti in generale (vedi riquadro). Anche l'insegnante di sostegno Martin Gürtler di Sek Leonhard è convinto che i bambini più forti traggano vantaggio dal sistema inclusivo perché, da un lato, sperimentano realmente la diversità della società e, dall'altro, godono di un sostegno più intenso.
Link e blog sul tema dell'inclusione:
- www.proinfirmis.ch: un'organizzazione specializzata per persone con disabilità che offre consulenza
- peterlienhard.ch/blog: Blog del professore dell'Università di Scienze Applicate per l'Educazione ai Bisogni Speciali con molti testi informativi e presentazioni video
- www.hfh.ch
- www.integrationundschule.ch
- www.myhandicap.ch
Quindi, se l'integrazione o l'obiettivo a lungo termine dell'inclusione portano benefici a tutti, perché spesso incontrano resistenza? «Alcune scuole non hanno risorse sufficienti, i politici spesso si lasciano prendere dal panico su questo tema complesso e i genitori sono così preoccupati per il successo scolastico dei loro figli che non vogliono essere coinvolti in esperimenti», riassume Lienhard.
Integrazione a qualsiasi prezzo?
Tuttavia, l'integrazione o l'inclusione «non solo non è accettabile per la maggioranza, ma non è nemmeno sempre sensata», sottolinea Lienhard. È importante considerare il singolo caso. Il bambino gravemente autistico, ad esempio, che va nel panico in gruppi numerosi, probabilmente sta meglio in una scuola speciale con piccoli gruppi, supporto individuale e psichiatri che in una scuola tradizionale.
E ci sono alunni il cui disturbo comportamentale rende le lezioni impossibili per tutti gli altri. Può anche accadere che gli alunni con gravi problemi di udito o di vista sviluppino strategie nelle scuole tradizionali in modo che nessuno si accorga che non capiscono nulla. Ma: «Il successo dell'integrazione non dipende solo dal bambino», sottolinea Lienhard. Spesso gli viene chiesto per quali disabilità l'integrazione ha senso e risponde con una mappa mentale.
Questo dimostra che: L'alunno è solo un pezzo del puzzle. Affinché l'integrazione e l'inclusione abbiano successo nelle scuole, i genitori, gli insegnanti, la direzione e le autorità scolastiche devono collaborare, devono essere disponibili locali e risorse e devono essere fornite consulenza e formazione esterne. «Se, ad esempio, i genitori di tutti gli altri alunni sono contrari all'inserimento in classe di un bambino disabile, quest'ultimo avrà molte difficoltà», spiega Lienhard.
Lezioni di lingua, piani di sostegno individuali, scrittura a mano più ampia: sono molti gli ausili disponibili.
L'inclusione non significa necessariamente che tutto venga fatto insieme e misurato con gli stessi standard. Ad esempio, gli alunni con bisogni speciali in contesti inclusivi ricevono voti solo se il loro rendimento è davvero paragonabile a quello degli alunni comuni. I loro obiettivi di apprendimento individuali - ad esempio, «fare la somma delle decine» - e una descrizione del loro grado di raggiungimento sono inclusi nella pagella.
Inoltre, non è stabilito da nessuna parte che gli alunni debbano sempre insegnare nella stessa stanza. Ad esempio, quando Sophie e gli altri bambini con status di integrazione della 4i di Sek Leonhard devono preparare una presentazione, gli insegnanti di sostegno li portano nell'aula dedicata. Qui possono parlare ad alta voce e il compito può essere spiegato più volte senza disturbare gli altri alunni. Il risultato viene poi presentato all'intera classe.
Inoltre, l'orario 4i lascia abbastanza spazio al programma settimanale personale degli alunni - e può capitare che un'alunna sommi 5 e 7 sul regolo calcolatore mentre il suo compagno al tavolo accanto calcola la distanza tra due città usando una mappa.
Per Christian Liesen, professore dell'Università intercantonale per l'educazione dei bisogni speciali, l'inclusione consiste nell'«immaginare come gli obiettivi educativi possano essere raggiunti senza limitare la propria immaginazione». Secondo Liesen, è fondamentale rendersi conto «che ci sono sempre diversi modi ragionevoli per raggiungere l'obiettivo».
Collaborazione editoriale: Martina Proprenter

Volete ricordare questo articolo sul tema dell'inclusione nelle scuole? Allora appuntate questa immagine sulla vostra bacheca Pinterest. Saremo lieti se ci seguirete su Pinterest.