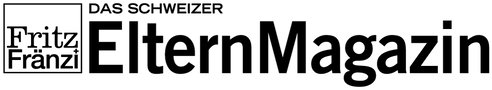Una visita alla scuola d'asilo
Al mattino, un piccolo autobus percorre la ripida stradina che attraversa il parco dell'ospedale cantonale. Si ferma davanti all'ultimo edificio ai margini del bosco e fa uscire un gruppo di scolari con zaini colorati. Passano in fretta davanti alla reception del centro per richiedenti asilo e all'ufficio dove i richiedenti asilo siedono, aspettano e discutono ad alta voce. I bambini sono in ritardo perché lo scuolabus è rimasto bloccato in un ingorgo. Si tolgono frettolosamente le giacche, le appendono ai ganci sul muro e si precipitano in classe. I loro compagni di classe sono già chini sui loro compiti. Hanno fatto un percorso più breve per arrivare a scuola: dai piani superiori del centro di accoglienza al piano terra. Gli insegnanti accettano di buon grado l'arrivo in ritardo dello scuolabus dei bambini provenienti dagli altri centri d'asilo. La situazione eccezionale è la norma qui.
I cantoni utilizzano diversi modelli
Nella scuola del centro per richiedenti asilo di Hirschpark, a Lucerna, la scuola inizia ogni quindici giorni. Gli alunni vengono mandati via quasi altrettanto spesso. Al momento della nostra visita, 48 bambini e ragazzi studiavano in sei classi, ma il numero è in continua evoluzione, di solito in crescita. Tutti i bambini in Svizzera sono tenuti a frequentare la scuola, indipendentemente dal loro status di residenza. Con il crescente afflusso di rifugiati, ci sono sempre più bambini che aspettano nei centri di transito cantonali che le loro domande di asilo vengano esaminate. Anche in questo periodo, l'istruzione è per loro un diritto e un dovere. I cantoni hanno modelli diversi a questo proposito. Dall'integrazione immediata in una scuola regolare con lezioni aggiuntive di tedesco a classi speciali di piccole dimensioni e classi scolastiche direttamente nei centri per richiedenti asilo, come nel caso di Lucerna. Una volta chiarito il loro status di asilo, i richiedenti tornano nei comuni - e quindi nelle scuole ordinarie - o nel loro Paese d'origine. In media, i bambini di Lucerna rimangono nei centri di transito per due o tre mesi. Tuttavia, c'è sempre qualcuno che si trasferisce dopo poche settimane. E ci sono anche quelli il cui status rimane incerto fino a un anno o più.
«Non possiamo insegnare a un analfabeta di 16 anni insieme ai bambini dell'asilo e agli alunni della scuola primaria».
La direttrice Silvia Rüttimann
Ogni alunno deve essere sorvegliato individualmente
Vedono i loro compagni di classe andare e venire in continuazione. Il divario è enorme Prima di essere suddivisi in classi, i bambini si presentano alla direttrice Silvia Rüttimann. La direttrice cerca di capire se i bambini hanno già frequentato la scuola, se sanno leggere e scrivere e se hanno imparato il latino o soprattutto i caratteri arabi. «Il divario è enorme», dice. Il compito più difficile è quello di classificare i bambini per livello, ma dando loro la possibilità di imparare con i loro coetanei. «Non possiamo mettere i sedicenni analfabeti insieme ai bambini della scuola elementare e dell'asilo», dice. Per gli otto insegnanti della scuola primaria, che hanno un carico di lavoro fisso nella scuola del centro per richiedenti asilo, questo significa soprattutto una cosa: devono occuparsi di ogni singolo alunno. Assegnare i compiti a ciascun alunno al suo livello, consentendogli di progredire e mantenendo il gruppo unito. Un costante gioco di equilibri.
Ecco perché di solito nelle classi non ci sono più di dieci alunni. L'acquisizione della lingua è al centro dell'attenzione e tutti gli insegnanti hanno una formazione supplementare in «tedesco come lingua straniera». Ogni alunno ha dieci lezioni di tedesco a settimana al mattino. Nel pomeriggio sono previste due lezioni di matematica, disegno e sport. E poi ci sono cose che si imparano anche senza essere nominate direttamente: dare una struttura alla giornata, prepararsi per la scuola.
«I bambini assorbono tutto, vogliono sapere tutto, senza riserve».
Insegnante Pia Schnyder Perrollaz
Questo è un problema particolare per i bambini più piccoli, gli alunni in erba della scuola primaria. Siedono a piccoli tavoli al primo piano e attaccano puntini colorati dietro a immagini e parole. Ogni punto corrisponde a una sillaba. Chi non è sicuro batte le mani insieme all'insegnante Pia Schnyder Perrollaz e all'apprendista Anis Ayachi e conta. «Re-gen-schirm». «Tempesta-vento». I bambini hanno appena imparato le parole, tratte da una storia su un riccio in letargo. Alcuni alunni si interrogano e riflettono così intensamente che sembra quasi di vedere il vapore che sale dalle loro testoline. Si strofinano il naso, serrano la bocca e provano: «Due?». «No, ascolta di nuovo!». Altri sospirano e scuotono la sedia con impazienza.

Ma c'è anche l'altro lato del lavoro al centro per richiedenti asilo. L'impareggiabile entusiasmo dei bambini. Ogni volta che Pia Schnyder Perrollaz fa una domanda, tutti i bambini alzano le dita con avidità e gridano «Io, io, io...». «Assorbono tutto, vogliono sapere tutto, senza alcuna riserva», dice l'insegnante. Allo stesso tempo, cercano la vicinanza. L'apprendista Anis, 22 anni, è particolarmente affezionato a loro. Forse perché, essendo per metà tunisino, parla anche arabo. Forse anche perché, come dice lui stesso, «non deve esercitare tanta autorità e a volte gli viene permesso di stare seduto lì». Ogni volta, uno dei bambini si avvicina a lui e si accoccola al suo braccio. Anche quando cantano insieme la canzone del riccio in letargo alla fine della lezione, a voce alta, in modo scorretto e con molto sforzo fisico. La direttrice Silvia Rüttimann sa per esperienza che alla maggior parte dei bambini piace davvero andare a scuola e non ha bisogno di essere convinta dai genitori. «La scuola è estremamente importante per tutti». E non solo per la materia. Si tratta anche di far uscire i bambini dalle condizioni di vita anguste del centro di accoglienza. Lo si vede chiaramente con la famiglia Rashid. Da quando sono arrivati in Svizzera dalla Siria, passando per la Turchia e la Germania, tre mesi fa, vivono due piani sopra la scuola, in una stanza piccola e pulitissima. Ci sono due letti a castello e una culla con un neonato. Ci sono anche un lavandino, un forno a microonde, un frigorifero e un tavolino - tutto qui. Qui vive una famiglia di sei persone. E tutti cercano di fare silenzio quando i tre figli in età scolare fanno i compiti. Padre Muhammed, che spesso si trova anche lui con un dizionario, li rassicura. «L'istruzione è importante», dice con aria seria. Si trova davanti a una parete su cui sono appesi gli orari dei bambini, insieme a foto ritratto. Sotto sono allineati i banchi di scuola e le scarpe. Fino a pochi mesi fa, nel centro di accoglienza c'era ancora una stanza dove i bambini potevano fare i compiti in tranquillità. Ma ora è stata adibita a camera da letto aggiuntiva.

Abituare i bambini alle strutture scolastiche è tutt'altro che facile, riferisce l'insegnante: «Molti non si sono mai seduti in cerchio, altri non hanno mai giocato». Per di più, alcuni dei bambini hanno un alto potenziale di aggressività - non conoscono la differenza con le loro famiglie. «Chiunque abbia il giocattolo in mano crede che ora gli appartenga, e altri si difendono a colpi e graffi», spiega Pia Schnyder Perrollaz. Questi momenti sono particolarmente impegnativi per lei come insegnante e come persona. Deve spiegare perché non è permesso picchiare in classe. E spesso solo con gesti ed espressioni facciali, perché mancano ancora le parole giuste.
Sussurri sull'insegnante
Ci sono solo alcuni adolescenti che a volte non sembrano così entusiasti delle lezioni. Per loro, l'insegnante è talvolta un motivo per sussurrare nella loro lingua madre. E ci sono ragazzi che devono essere ammoniti tre volte prima di spegnere il cellulare. Ciò può essere dovuto alla pubertà. Forse anche perché hanno la strada più difficile da percorrere. In poche settimane o mesi, i ragazzi dovrebbero imparare il tedesco così bene e ricevere le prime materie scolastiche così bene che presto potranno frequentare «la classe scolastica di livello più basso ancora accettabile per la loro età». Così dice la direttrice Silvia Rüttimann. Ecco perché queste classi sono molto meno giocose di quelle più giovani.
Sono impegnati nella coniugazione dei verbi. «Io bacio, tu baci...». «Sai cosa significa baciare?», interviene l'insegnante, e la ragazza afghana forma timidamente una bocca da bacio sotto il foulard. «Sì, esattamente!». Poi elogia una bambina eritrea per aver coniugato correttamente il verbo «correre» - senza leggere, perché lei non sa ancora leggere. In un'altra classe, l'insegnante Heidy Müller lancia di tanto in tanto una parola in farsi o in arabo quando la comunicazione si blocca. Tuttavia, ammette con autocritica di dimenticare la maggior parte di esse subito dopo che gli alunni gliele hanno insegnate. «Trovo ancora più ammirevole quello che i bambini riescono a fare qui».
La maggior parte di loro parla tedesco con frasi brevi. «Vengo dalla Siria». «Ho 14 anni». Funziona. Inoltre: «Ho due sorelle». Ma perché sono rimasti con i loro genitori in Siria, perché il ragazzo che racconta questa storia è venuto in Svizzera da solo, le parole tedesche mancano ancora. Invece, sorride e scrolla le spalle. Una cosa è chiara: non è l'unico qui senza famiglia. Nel cantone di Lucerna è stato allestito un centro speciale per circa 70 cosiddetti UMA, ovvero «minori non accompagnati richiedenti asilo». Una sfida particolare per gli insegnanti? Silvia Rüttimann: «Raramente notiamo un trauma. Solo occasionalmente un genitore dice qualcosa quando si tratta di spiegare il comportamento dei bambini». Tuttavia, ciò che i bambini hanno vissuto non è normalmente un argomento trattato in classe. L'insegnante Pia Schnyder Perrollaz ne è convinta: «Prima di tutto, i bambini sono impegnati ad arrivare, e ciò che devono affrontare diventa evidente solo molto più tardi, quando si sono calmati».
Per saperne di più:
- Und wie geht es weiter nach der Schule im Asylzentrum? Wir haben die 14-jährige Amina bei ihrem Schritt in die Regelschule begleitet.