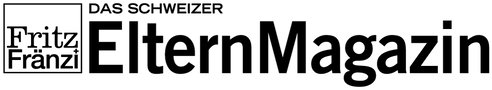Conversazione invece di interrogatorio: come posso parlare con mio figlio?
Signora Döpfner, quando all'ora di pranzo chiedo a mia figlia come è andata la scuola o come è andato l'esame, sento spesso una sola parola: «bene». Perché i bambini sono così monosillabici?
Di solito ciò è dovuto al comportamento dei genitori. Spesso non ci impegniamo veramente con i nostri figli, non diamo loro la massima attenzione e siamo distratti da telefonate o e-mail. Inoltre, non sempre comunichiamo in modo empatico, ma i nostri tentativi di dialogo assomigliano a degli interrogatori: Siamo interessati a determinate informazioni fattuali e orientiamo la conversazione di conseguenza. Il risultato è che il bambino si sente sotto pressione ed evita la conversazione. Perché fa questa domanda a sua figlia?
Perché mi interessa davvero sapere com'è stato l'esame.
È proprio per questo che dovete ascoltare attentamente vostro figlio e prestare attenzione alle sfumature. Se risponde con leggerezza: «Oh sì, il lavoro di inglese è andato benissimo», probabilmente non c'è bisogno di parlare. Se invece dice: «Beh, non lo so nemmeno io», di solito è utile seguire con attenzione. «Sembri un po' deluso: speravi in qualcosa di più?». In questo modo si affronta l'impressione generale che il bambino sta dando. Il che è più promettente di: «Come? Non ti sei esercitato abbastanza?». Per fare questo, però, dobbiamo essere attenti ed empatici: solo così il bambino si sentirà compreso e sarà disposto a parlare.
E se risponde in modo evasivo?
A questo punto è meglio dire al bambino, senza rimproveri nella voce: «Ho l'impressione che tu non voglia parlarne - può essere?». Se il bambino si sente compreso, può continuare a parlare. Se invece lo spingiamo a parlare, spesso si chiude completamente.
Cosa succede rapidamente nella vita di tutti i giorni. Quando vale la pena di riprendere il lavoro in inglese?
Lasciate che il bambino arrivi per primo, aspettate un momento di tranquillità e poi provate. A volte, però, i genitori devono accettare che il figlio non voglia parlare. È importante non interpretarlo come un rifiuto di sé, ma rimanere disponibili a parlare.
Lei dice che le conversazioni possono creare vicinanza con poco sforzo. Che cosa ci vuole?
L'attenzione è molto importante: una volta al giorno ci si deve concentrare sul bambino, senza alcuna distrazione. Lo sappiamo da noi stessi: Se qualcuno lascia squillare il cellulare e dà la priorità a parlare con noi, ci sentiamo apprezzati. L'ideale sarebbe che i genitori fossero aperti e curiosi.
In che senso?
Quando parlo con mio figlio, l'attenzione non deve essere rivolta all'atteggiamento «Come voglio che mio figlio sia?», ma all'interesse sincero: «Chi è in realtà questa persona?». Anche l'ascolto attivo è utile: se i genitori inizialmente si trattengono da suggerimenti e giudizi e ripetono ciò che sentono dal figlio, quest'ultimo si sente compreso perché può orientare la conversazione nella direzione per lui importante. Anche i rituali di conversazione sono utili. Ad esempio, quando a cena si discute della «domanda del giorno»: Qual è stata la cosa più divertente di oggi? Cosa ti ha infastidito? Chi hai aiutato? Ogni membro della famiglia, a turno, deve riferire, compresi i genitori. In questo modo, sia gli adulti che i bambini parlano da pari a pari all'altezza degli occhi, il che è molto stimolante per i bambini perché non c'è un interrogatorio, né una comunicazione dall'alto verso il basso. Inoltre, si crea vicinanza quando i bambini vengono a conoscenza della giornata dei genitori e non solo del contrario.
«I nostri tentativi di dialogo assomigliano a degli interrogatori: Siamo interessati a determinate informazioni e orientiamo la conversazione di conseguenza».
Uno scambio per il quale spesso non c'è spazio nella nostra vita quotidiana densamente organizzata.
Per questo è ancora più importante creare uno spazio per questo. A questo scopo ho sviluppato le «100 domande» nell'appendice del mio libro. Riflettere insieme su «Che cosa rende un buon amico?» o visualizzare «In che cosa vorrei essere davvero bravo?» crea vicinanza. In questo modo, si impara molto di più sull'altro rispetto a quando si chiedono solo informazioni concrete. Questo arricchisce immensamente entrambe le parti.
In genere i bambini vogliono parlare di qualcosa di importante quando in realtà non c'è tempo per farlo. Al mattino, quando tutti stanno uscendo di casa, per esempio.
È vero. È interessante notare, però, che di solito non ci vuole così tanto tempo. L'intera questione è più che altro un problema mentale: siamo troppo assorbiti da tutti i punti della nostra agenda quotidiana per essere coinvolti e discutere improvvisamente di grandi questioni sulla vita e sulla morte.
Ecco perché di solito soffochiamo queste conversazioni con «Non lo so» o «Ne parliamo dopo».
Che per me sono occasioni perse! Ma se riusciamo a staccarci dallo stress del momento e a fermarci un attimo, fa una grande differenza: impariamo qualcosa dal nostro bambino. Dopo, di solito il momento è passato e il bambino non è più interessato. I bambini vivono nel qui e ora.
I genitori non dovrebbero giudicare o dare consigli, direte voi. Ma se mia figlia litiga con la sua migliore amica, vorrei darle un consiglio.
Certo che potete, ma non come reazione impulsiva. Altrimenti priverete vostra figlia della possibilità di sviluppare le proprie soluzioni. Se noi genitori diciamo sempre «Fai così!» o «Non fare così!», i bambini non possono sentirsi competenti. L'importante è non imporre il nostro punto di vista al bambino, ma ascoltare prima. Poi il bambino può specificare come si sente e parlerà in modo molto più dettagliato perché si rende conto: «Sono capito!». Per i genitori, all'inizio è strano essere così riservati con le proprie opinioni e i propri consigli.
Anche molti adulti non riescono a fare un passo indietro in una conversazione. La comunicazione è molto spesso a senso unico, le persone inviano ma non ricevono.
In realtà è proprio così. Quando parliamo di qualcosa, l'altra persona spesso non approfondisce affatto, ma si limita a dire: «Una volta ho vissuto un'esperienza simile, era così...» e parla di sé. Ma io stavo solo parlando di me stesso! Molte persone si limitano a dirottare le conversazioni e non c'è un vero dialogo che avvicini le persone. Per questo è ancora più importante che i bambini crescano in una buona cultura del dialogo, in cui imparino a trasmettere e ricevere quando comunicano.
Spesso è difficile riconoscere i sentimenti. Se il bambino di sette anni è imbronciato, non serve chiedere: «Cosa c'è che non va?».
Anche questo suona subito come un rimprovero. Per questo preferisco cercare di intuire: «Sei infelice in questo momento, vero?». Al che lui potrebbe rispondere: «No, sono arrabbiato!». Questo gli dà la possibilità di dare un nome al sentimento. Sta a noi aiutare un bambino a imparare a parlare dei propri sentimenti. Mi capita spesso di avere a che fare con giovani che sanno solo dire: «Non mi sento bene». Non sono in grado di definirlo ulteriormente perché non si sono mai esercitati a parlare dei loro sentimenti.
Come possono i genitori sostenere concretamente i propri figli?
Date l'esempio, date un nome ai vostri sentimenti, parlate di voi stessi. Ad esempio: «Oggi non mi sento bene, sono così stanco e stressato». Ma anche: «Oggi ho vissuto un'esperienza fantastica, sono molto felice!». Tra l'altro, gli studi dimostrano che le madri parlano alle figlie con molte più emozioni rispetto ai figli maschi. Di conseguenza, le ragazze hanno un vantaggio quando si tratta di parlare di sentimenti. Il frequente rimprovero che le donne rivolgono agli uomini: «Non parli dei tuoi sentimenti» è quindi in una certa misura una socializzazione. Per questo è ancora più importante cercare di parlare di sentimenti con i ragazzi allo stesso modo che con le ragazze.
«È importante che i bambini crescano in una cultura del dialogo in cui imparino a inviare e ricevere».
Perché è così importante che i bambini parlino di sé?
Perché li aiuta a comprendere e organizzare le emozioni e gli eventi della loro vita. E perché creano connessione e vicinanza condividendo cose personali, belle e anche tristi. Rivelano qualcosa di loro stessi e danno così all'altro la possibilità di capirli. Se i bambini imparano a parlare di sé e dei propri sentimenti, saranno anche più pronti a interessarsi ai sentimenti dei loro compagni.
Quando i bambini raggiungono la pubertà, i genitori spesso si preoccupano di non riuscire a ottenere abbastanza da loro.
In questo periodo i giovani si ritirano, i genitori perdono importanza a favore degli amici: è uno sviluppo del tutto normale. I genitori non devono considerarlo un rifiuto. Naturalmente, gli adolescenti che stanno diventando indipendenti non sono più così prevedibili nella vita familiare, nemmeno per le conversazioni quotidiane. Per questo è ancora più importante che i genitori segnalino la loro disponibilità: «Sarò a casa per la prossima ora o due; se vuoi parlare, prendere una tazza di tè o fare una passeggiata, vieni a trovarmi».
E se non funziona?
La cosa più importante è non offendersi se l'offerta non viene accettata subito. Al contrario, continuate a proporre conversazioni e rimanete in gioco. Non archiviate la questione sotto la voce: «Non è interessato, lasciamo perdere», altrimenti il giovane penserà: «Tanto i miei genitori non sono interessati», e si creerà un circolo vizioso. Spetta ai genitori continuare a proporre uno scambio e mostrare una certa flessibilità. La pubertà non significa necessariamente alienazione tra genitori e figli: genitori e figli possono anche sperimentare la vicinanza in questo periodo così emozionante.
Per saperne di più sulla comunicazione in famiglia:
- Autotest: Ascolto e dialogo orientati ai bisogni
Basta con gli interrogatori dei genitori, ma conversazioni aperte e attenzione totale! Da oggi parleremo di cose che di solito non trovano spazio nella vita quotidiana: un autoesperimento di comunicazione.
- Da un orecchio all'altro?
All'improvviso qualcuno grida e le porte vengono sbattute. La comunicazione in famiglia è una cosa difficile, soprattutto perché i bambini a volte si spengono. Cinque esempi tratti dalla vita di tutti i giorni e come migliorare la situazione.
- Porre fine alla rigidità dei ruoli: ascoltate!
Molti genitori ricorrono a comportamenti di disturbo con i propri figli perché temono di perdere il comando. Secondo Jesper Juul, l'empatia e il dialogo genuino li aiuterebbero a stabilire dei limiti.